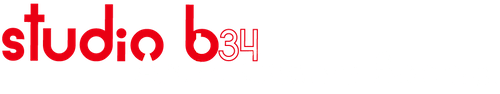Nelle considerazioni che seguiranno verranno analizzate soltanto le scelte del progettista che, in quanto umane, in questo ambito devono essere scelte morali relative al suo essere “uomo ed Architetto” quando egli stesso si chiama a progettare.
Alla domanda “cosa è bene per l’uomo e quale senso abbia la sua vita” corrisponde, in Architettura, “cosa sia una buona Architettura, a cosa debba tendere per essere tale”.
Come l’esperienza morale mette in connessione l’Io e gli altri verso il compimento di una vita buona, e giusta, attraverso un continuo agire, e quindi con risvolti morali, così l’esperienza del progetto architettonico mette in relazione “se stessi” e gli altri all’interno della triade costituita con il mondo.
Diventano così fondamentali le scelte progettuali volte alla costruzione di un ambiente che nell’avere inevitabilmente relazioni con il “tutto”contempla l’assoluto.
Ma quali sono le scelte buone da fare per un buon progetto? Quale è il giusto atteggiamento da adottare perché si possa ottenere Architettura?
Per rispondere a queste domande bisogna innanzitutto addentrarsi nella disciplina progettuale con sguardo etico, vedere, cioè, elementi, strumenti e prassi progettuali, all’interno di un processo teleologico che ha come obiettivo quello di costruire Architettura volta a fare da sfondo essenziale al compimento della vita dell’uomo.
- Per prima cosa scegliere l’approccio etico al progetto. L’Architetto deve essere cosciente del compito che è chiamato a svolgere e soprattutto non perderlo di vista nel percorso progettuale.
- Avere un approccio etico significa vedere il proprio operare all’interno di un quadro ambientale fisico di inevitabile carattere naturale e di carattere antropizzato. Quindi saper riuscire ad individuare quali siano le valenze distintive dell’ambiente utilizzando una chiave di lettura che pone al centro le generalità del carattere umano e non solo le sue specifiche esigenze contingenti, alle quali, spesso, con il progetto si è chiamati a dover dare risposta.
- Una volta individuati i caratteri ambientali rientranti all’interno della disciplina, procedere nel pieno rispetto di questi utilizzando lo stesso parametro interpretativo della fase precedente.
- Queste fasi, approccio, analisi e progetto, sono presenti in qualsiasi azione o fatto antropizzante. La differenza sta nell’avere piena coscienza di poter operare scelte morali all’interno di questi processi.
Primo punto. Scegliere di avere un approccio etico significa aprirsi agli altri e al mondo fisico pienamente consapevoli che ciò a cui il progettista è chiamato a rispondere ha un legame fortissimo con il senso della vita, e che quanto accade nel mondo, costituisce il tutto. E ciò non ha altro modo di accadere se non nel mondo.
L’approccio morale al progetto è una scelta che l’Architetto deve attuare in quanto all’ambiente fisico nessuno può sottrarsi:
- Architettura etica diventa il tener conto prioritariamente degli aspetti umani nel loro complesso pur dovendo rispettare il compito contingente dato dal progetto particolare, il quale nasce per soddisfare esigenze puntuali e quasi mai di ordine generale. L’architetto deve essere cosciente, perciò, di essere sempre conteso tra due committenti, il genere umano col suo bisogno di trascendenza e quello contingente legato alle esigenze della committenza.
- A questo va aggiunto un altro aspetto molto importante, che vede nella stessa persona l’uomo e il progettista. E’ difficile stabilire la linea distintiva tra l’uno e l’altro nella fase progettuale, ma per entrambi i “ruoli” valgono le stesse prerogative etiche. Pertanto la prima domanda etica alla quale il progettista è tenuto a rispondere riguarda il sentirsi all’altezza del compito. Nel caso contrario, è tenuto a rinunciare.
Mentre il contributo personale al progetto è fatto da ciò che siamo come uomini, il contributo come Architetti è legato alla sua espressa volontà di migliorarsi e acquisire continue conoscenze in questo campo. Quindi diventa un’esigenza di ordine etico il perseverare nello studio, nell’esercizio, nel tenersi aggiornato, sia come Architetto che come uomo.
Queste pratiche sono a pieno titolo scelte etiche, visto il compito preparatorio che svolgono, nel guidare le scelte formali del progettista. Di questo tipo ve sono molte altre che rientrano nella prima fase preliminare e che meriterebbero, come quelle enunciate, un adeguato approfondimento.
Secondo punto. Questo riguarda il definire un ordine gerarchico di importanza “delle unità minime omogenee” che costituiscono il contesto del progetto, siano esse naturali che antropizzanti.
Essendo la preesistenza ambientale a dover essere modificata, ad essa bisogna rivolgere il primo sguardo analitico, in quanto ciò che verrà realizzato assumerà quel determinato valore proprio in relazione al contesto nel quale si realizzerà. Individuare pertanto le unità minime omogenee e metterle in relazione gerarchica, costituisce la prima fase operativa del progetto, che influenzerà in maniera determinante l’esito formale finale.
Perché è possibile parlare di scelte etiche in questa fase?
L’etica pone le basi dello sguardo sul mondo: in un certo senso costituisce il nostro modo di vederlo e viverlo. Anche per l’analisi progettuale si tratta di selezionare, ordinare e mettere in relazione eticamente valenze ambientali (unità minime omogenee) prioritariamente con sguardo etico.
Ciò e possibile leggendo l’ambiente dal punto di vista dello spirito umano, il quale riconosce e seleziona gli elementi con i quali meglio si trova in sintonia.
Leggere così l’ambiente significa darne una prima lettura determinante per le future scelte progettuali, nel senso che queste ultime saranno adeguate se, e solo se, rispetteranno un’analisi etica.
Analizzare eticamente l’ambiente significa darne una lettura che considera l’uomo in quanto tale, cioè essenza in cerca del senso della vita.
Risulta difficile ad ora dare un connotato come questo all’uomo, più facile assimilarlo ad un ruolo o etichettarlo come: lavoratore (pensionato attivo), pensio-nato (pensionato passivo), consumatore, giovane, vecchio, ecc..
La visione etica dell’ambiente deve vedere l’uomo al di là della sua contingenza sociale parametrico-prestazionale ed analizzare l’ambiente individuando le valenze adeguate alla costruzione di un ambiente trascendente. Entrare in relazione con la forma delle unità ambientali costituirà la base disciplinare alla quale riferire le scelte formali.
Per esempio, per qualsiasi progetto l’incidenza dell’ambiente naturale è determinante, ma potrebbe passare in secondo piano o addirittura non essere nemmeno presa in considerazione, nel privilegiare essenzialmente le prestazioni funzionali richieste dal progetto. Questo tipo di atteggiamento nell’escludere aspetti come la luce naturale, l’orientamento degli affacci dall’interno, eventuali valenze paesaggistiche ed altri aspetti puntuali, escludono a priori la relazione uomo-natura propria dello spirito umano.
Al contempo un atteggiamento contrario che escludesse gli elementi antropizzanti emblematici della storicità di un luogo, espressione anch’essi dello spirito umano, risulterebbe altrettanto forzato e parziale nel determinare la resa formale del progetto.
Seppur appena abbozzata l’analisi progettuale in un’ottica etica, viene messo in evidenza il ruolo determinante per lo sviluppo del progetto.
Terzo punto. Determinante per la resa formale è l’atteggiamento etico nelle scelte progettuali. Maggiore è l’incidenza del progetto all’interno dell’ambiente (dimensione, funzione pubblica, centralità di collocazione), maggiore deve essere l’attenzione da porre all’aspetto etico.
Infatti ogni elemento fisico dell’ambiente, sopratutto se di notevole rilevanza, incide sulla qualità spaziale e pertanto si genera nei suoi confronti una sorta di riverenza dovuta all’eccezionalità dello stesso, tanto che l’apprezzamento di tale manufatto è pressoché unanime.
Come accennato si tratta di dare forma alla materia, adottando criteri compo-sitivi coerenti e pertinenti ad alcuni fondamentali aspetti della progettazione, come il linguaggio architettonico, la tipologia edilizia, lo spazio e l’espressività della relazione tra forme ed elementi costitutivi. Tutto ciò, unitamente agli altri strumenti che determinano il controllo generale del progetto, determina un buon risultato.
Questi elementi se valutati sotto il profilo etico, acquistano una valenza che diversamente non potrebbero avere, ciò in relazione al fatto che ad unire tutte queste fasi non è solo il risultato formale finale, ma soprattutto il senso ultimo della loro realizzazione.
Quindi a fare da filo conduttore va fatto rientrare a pieno titolo anche il valore etico del risultato formale finale del progetto. Quel valore dato dall’opportunità di trascendere la contingenza per approdare all’assoluto.
Gli elementi con cui lavora l’architetto sono portatori di una propria dignità, conferitagli dall’uomo stesso. Questa, se rispettata, è garanzia di un buon esito finale del progetto.
L’approccio etico sta nel considerare questi elementi come entità ontologiche degne di rispetto morale. Solo così esse possono essere considerate parti attive del progetto, tali da concorrere, unitamente al progettista, alla creazione di Architettura.
A tal proposito cito un’articolo apparso sulla rivista “urbanistica” N150-151 del giugno 2013 (26) che mette in evidenza quali siano gli interrogativi in merito alla questione Ambientale nel suo complesso :” …sono sempre più improponibili le diverse modalità della professione che hanno effetti socialmente rilevanti, e perchè la disciplina deve fare i conti con se stessa e stabilire se limitarsi a fare progetti, piani e programmi o andare oltre.”
Ad oggi siamo a questo livello, rappresentato dalla domanda “se andare oltre”, come se fosse un aspetto eludibile dal ruolo fondamentale del progettista nel momento in cui “crea” il proprio e altrui ambiente di vita.
Andare oltre secondo me è un’obbligo morale che ognuno di noi ha, nei confronti di se stesso e della collettività, nel momento in cui si propone di apportare delle modifiche fisiche all’Ambiente, a qualsiasi livello esse si attuino, dal decidere dove collocare una panchina o dove far passare un’ autostrada. L’approccio deve “necessariamente” essere il medesimo, cioè il richiamarsi a valori etici che rispettano l’Ambiente dato dalla triade “io, gli altri, l’Ambiente fisico”.
L’obiettivo è quello di far si che le modifiche Ambientali costituiscano un “agire” in luogo di una successione scomposta dettata dal “fare”.